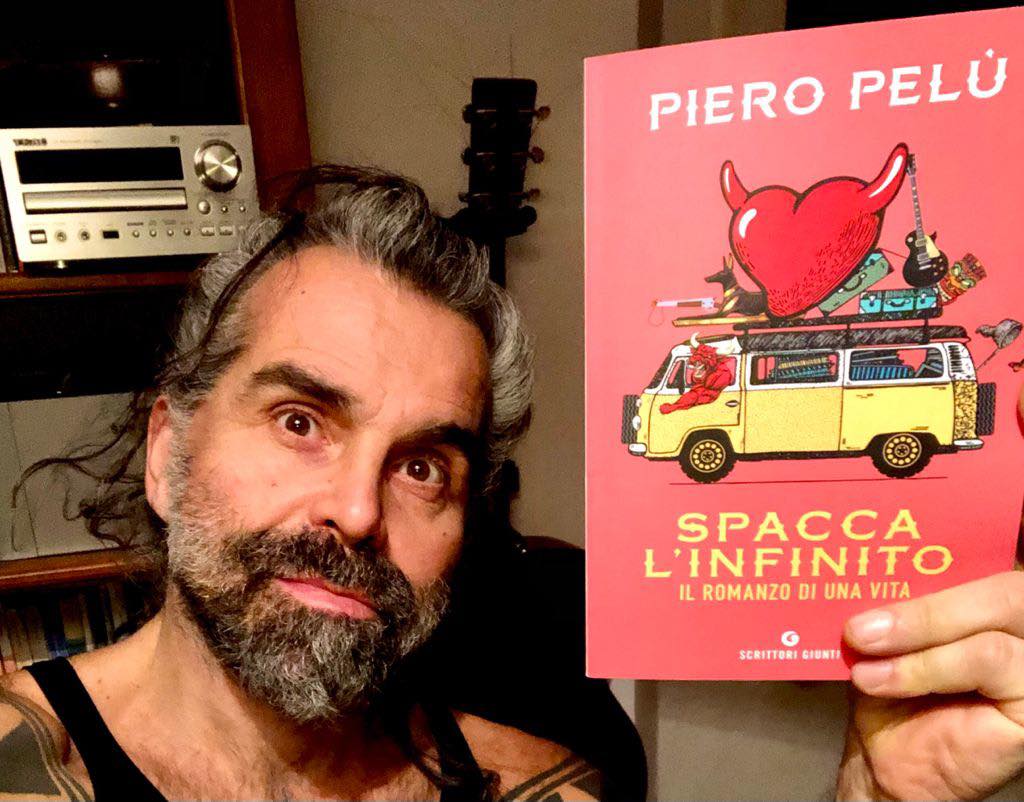“La Patente” di Pirandello: umorismo e pessimismo dal sapore agrodolce
Pubblicata nel 1911 e poi confluita nella celebre raccolta Novelle per un anno, “La patente” è testo assolutamente emblematico sia per la poetica di Pirandello sia per alcune costanti filosofiche dello scrittore siciliano. La vicenda narrata ripercorre le tematiche principali della scrittura pirandelliana, mettendo in scena il dramma tipicamente novecentesco di un ”io” scisso e privato della sua stessa identità, che, per esistere, è costretto ad assumere la “maschera” che gli altri calcano a forza sul suo volto, temi che ritornano ne “Il fu Mattia Pascal” e che si ritrovano sia nella ricca produzione teatrale sia nei successivi romanzi, come “Uno, nessuno e centomila“.
Leggi anche: Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes e il giallo deduttivo
Un modesto impiegato del monte dei pegni, Rosario Chiarchiaro, viene licenziato perché sospettato di essere uno iettatore. L’uomo sporge denuncia presso la magistratura contro due giovani, che al suo passaggio avrebbero fatto il classico gesto di superstizione popolare delle “corna” per allontanare il malaugurio. Il giudice si trova allora di fronte ad un caso paradossale, dato che, in quanto esponente della legge e della razionalità, non può in alcun modo cedere alle credenze popolari riguardanti la sfortuna né può tutelare in alcun modo gli interessi di Chiarchiaro che, a causa delle malelingue del paese, oltre ad aver perso il posto di lavoro, non riesce a far sposare le figlie ed è costretto a tenere segregata in casa l’intera famiglia contro le malelingue del paese.
La situazione, fortemente intrisa dell’umorismo pirandelliano e dell’inevitabile pessimismo esistenziale che in tutte le sue opere lo accompagna fedelmente passo dopo passo, si complica ulteriormente quando Chiarchiaro è convocato in tribunale per dare la sua versione dei fatti: anziché difendersi o ritirare la denuncia, il poveruomo, vestitosi per giunta da autentico menagramo, reclama con ostinato coraggio e convinzione di andare a processo, e anzi di poter ottenere un riconoscimento – una patente, appunto – del suo status di “porta sfortuna“.
“Rosario Chiarchiaro s’è combinata una faccia da jettatore che è una meraviglia a vedere. S’è lasciato crescere su le cave gote gialle una barbaccia ispida e cespugliuta; s’è insellato sul naso un pajo di grossi occhiali cerchiati d’osso che gli danno l’aspetto di un barbagianni; ha poi indossato un abito lustro, sorcigno, che gli sgonfia da tutte le parti, e tiene una canna d’India in mano col manico di corno”
Leggi anche: L’Aquila 2009-2021, la luce attraversa il cemento nella notte del ricordo
L’analisi di Chiarchiaro è tanto acuta quanto spietata; se il mondo gli ha imposto, nella sua rozza ignoranza, una “maschera”, tanto vale accettare di propria volontà questa sorta di grottesca parte teatrale, fino a ricavarne un giusto tornaconto, fino a trasformare la propria coatta condizione in una vera e propria professione.
Chiarchiaro è costretto nella forma dello jettatore dalla stupidità e dalla cattiveria dei suoi concittadini, e cerca di liberarsene in un modo del tutto inconsueto: non tenta, infatti, di uscire dalla maschera, vuole, invece, renderla proficua, vuole che sia la sua identità, perciò non sarà più jettatore per diceria, ma jettatore patentato dal regio tribunale, grazie al documento da lui stesso richiesto
“Mi pagheranno per farmi andar via! Mi metterò a ronzare intorno a tutte le fabbriche; mi pianterò innanzi a tutte le botteghe; e tutti, tutti mi pagheranno la tassa, lei dice dell’ignoranza? io dico della salute! Perché, signor giudice, ho accumulato tanta bile e tanto odio, io, contro tutta questa schifosa umanità, che veramente credo d’avere ormai in questi occhi la potenza di far crollare dalle fondamenta una intera città!”
Leggi anche: Il Piccolo Principe, 78 anni dell’opera di Saint-Exupéry
Chiarchiaro diviene così un tragicomico se non addirittura grottesco impiegato comunale, stipendiato perché non causi il malocchio al resto della cittadinanza. Il protagonista, da vittima, si fa persecutore; il suo gesto, apparentemente folle oltre ogni umana comprensione, risulta saggio; l’appellativo attribuitogli, da ingiurioso diventa utile. L’ignoranza e la superstizione hanno fatto di Chiarchiaro un improbabile spietato vendicatore. La sua storia, che può essere ritenuta divertente e caricaturale, è comunque triste e commovente. Cela, sotto uno strato di sapiente umorismo, una vena di profonda amarezza e di autentica pietà e diventa emblematica della beffa della vita e delle menzogne in cui l’uomo si dibatte, in una società ignorante e superstiziosa.
Sono centrali, ne La Patente, le tematiche più riconoscibili della scrittura pirandelliana: la moltiplicazione della personalità umana e la contraddittoria libertà che deriva dall’assumere un travestimento sociale di fronte agli altri, non importa quanto assurdo ed irrazionale.
Proprio per questo motivo, Pirandello rielabora la novella in una fortunato atto unico (prima in dialetto siciliano e poi in lingua nazionale) del 1917, che bissa clamorosamente il successo del racconto breve; qui, per giunta, la beffa del protagonista ai danni della giustizia si basa su una geniale invenzione drammaturgica, un ulteriore colpo di scena finale, in cui Chiarchiaro fa crollare a terra la gabbia di un povero cardellino, dimostrando esplicitamente il proprio “potere”, e di conseguenza l’urgente necessità della “patente” ufficiale di iettatore. Chiarchiaro verrà poi interpretato da Totò nel film ad episodi Questa è la vita (1954), diretto da Luigi Zampa.