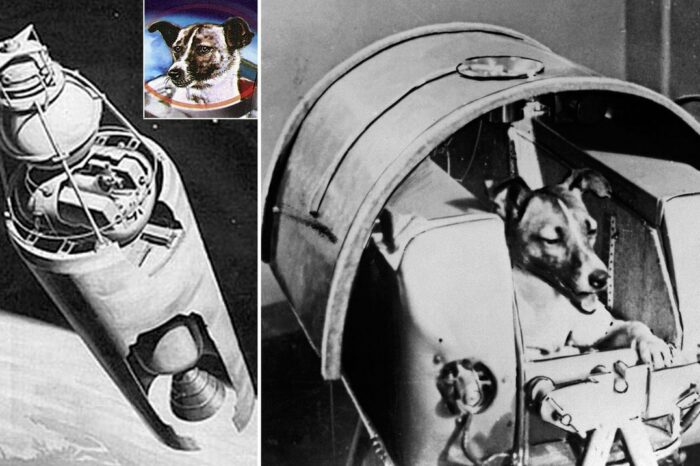Keep The Faith, cioè l’album perfetto dei Bon Jovi
Ogni volta che ascolto Keep The Faith dei Bon Jovi, la mia coscienza musicale compie un viaggio transoceanico e dalla Land of Dreams si trasferisce nella Terra d’Albione, torna al 1987 e posa l’attenzione sul quel capolavoro che fu Hysteria dei Def Leppard. E’ un parallelismo inevitabile, quello che scatta non appena il rullante di Tico Torres dà il via a “I Believe“, prima traccia del disco della band proveniente dal New Jersey. La formazione inglese, in quel masterpiece uscito cinque anni prima del quinto studio album del Bon Jovi, seppe dare il meglio di sé grazie a una prestazione oggettivamente sugli scudi.
Leggi anche: L’America del 2020 vista dagli occhi dei Bon Jovi: la recensione dell’album
Leggi anche: Jon Bon Jovi canta l’omicidio di George Floyd nel nuovo singolo “American Reckoning”
Ecco quindi che il sopra citato parallelismo trova terreno fertile in un primo aspetto: quello della tracklist del pattern. In entrambi i casi, le prime sei tracce sono diventate singoli, e ognuna di esse è stato un successo straordinario. Tra hit anthemiche, classici senza tempo, ritornelli che di prepotenza sono entranti nell’immaginario collettivo, gli album hanno rappresentato l’apice compositivo delle due band. E questo, almeno per chi scrive, è il secondo aspetto in comune. Ma siccome ciò vale per moltissimi ma non per tutti, sentenziare con tale espressione sarebbe ingeneroso e poco conveniente. Il concetto del De Gustibus è fortunatamente ancora la stella polare che guida il pensiero critico dell’ascoltatore.
Ulteriori aspetti in comune: l’aver scritto pagine indelebili della storia del rock, tra dischi sensazionali e concerti leggendari e – nota dolente – l’aver perduto, causa l’inesorabile decorso del tempo che non risparmia nessuno, lo smalto dell’epoca d’oro. E’ innegabile che da questi full-lenght in avanti e Bon Jovi e i Def Leppard abbiano zoppicato, e che i successivi These Days e Adrenalize siano stati, forse, gli ultimi episodi di spessore di una carriera da avrebbe vissuto tra più ombre che luci. Soprattutto per gli inglesi.
Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Tico Torres e David Bryan hanno continuano a produrre lavori interessanti con qualche vetta notevole, rappresentata per lo più da singoli di successo (“It’s My Life“, “One Wild Night“, “Everyday“, “Have A Nice Day“) scritti con una formula ultra collaudata (e dopo un po’ anche palesemente ruffiana – va detto), senza mai convincere appieno con album all’altezza dei precedenti. Eccezion fatta, forse, per Crush, disco scala classifiche capace di vendere circa 16 milioni di copie. Ma, per quanto interessante e sicuramente di qualità, le sonorità presenti al suo interno furono più leggere e pop, rimarchevoli, una volta di più, del cambio di rotta dei Bon Jovi, ormai lontani dal glorioso passato. Un po’ per scelta, un po’ per necessità.
Keep The Faith, pubblicato il 3 novembre del 1992 dalla Mercury Records, è un disco a larghi tratti perfetto. Se il precedente New Jersey (più di 20 milioni di copie vendute) fu un bella presa di posizione dalle sonorità glam/aor degli anni addietro (che epoca meravigliosa!), K.T.F. rappresentò un ulteriore cambio di marcia. Una produzione ben più diretta, meno pomposa e più moderna contribuì a dare spessore e potenza al sound globale dei dodici pezzi presenti nella tracklist (14 nelle versioni esclusive per alcuni mercati internazionali) registrati ai Little Mountain Studios di Vancouver.
Leggi anche: Il miracolo rock di Jon Bon Jovi: Moscow Music Peace Festival, l’atto di pace tra Stati Uniti e Unione Sovietica
La presenza di Bob Rock è un valore aggiunto, capace di manifestare quell’impatto che Bruce Fairbairn non riuscì ad attribuire a New Jersey. Tra il 1989 e il 1990 Rock aveva lavorato a Sonic Temple dei The Cult, a Dr. Feelgood dei Motley Crue e all’omonimo dei Metallica, meglio conosciuto come Black Album. Un discreto biglietto da visita su cui contare per compiere l’ennesimo salto di qualità. Le analogie, in termini di mixaggio e produzione del prodotto finale, sono evidenti. Vi sono due brani (“Keep The Faith” e “I’ll Sleep When I’m Dead“) che presentano la collaborazione di Desmond Child, mentre una sola vede quella di David Bryan (“In These Arms“), tutto il resto è opera di Jon Bon Jovi e Richie Sambora.
L’opener “I Believe” è una chiamata alle armi, un urlo in pieno stile Bon Jovi per affermare che la band è più in forma che mai e, soprattutto, per ricordarci di non credere a tutto ciò che la tv ci propina. “Keep The Faith“, tutt’ora tra i brani più trasmessi alla radio, è una canzone piena di speranza. Dinamica nel ritmo e coinvolgente nell’incedere, spiana la strada alla successiva “I’ll Sleep When I’m Dead” che invita l’ascoltatore a darsi da fare quanto più possibile perché, molto semplicemente, di tempo per dormire ce ne sarà fin troppo. “In These Arms” è tra le ballate più belle mai scritte dalla band. Presenta tutti i marchi di fabbrica tipici della band e anticipa, nello stile e nell’espressività, la futura “Always“. Come grida Jon: “Baby, ho bisogno di te, come le rose hanno bisogno della pioggia e i poeti hanno bisogno del dolore“.
“Bed of Roses” è, invece, la classica ballad. Qui, Jon, dà il meglio di sé. Lenta e smielata, scritta appositamente per fare breccia nei cuori dei fans (ma, principalmente, delle fans) è semplicemente una hit inarrivabile. Provateci quanto volete, non riuscirete a eguagliarla. Non ci sono riusciti neanche i Bon Jovi. Dal vivo viene spesso eseguita in spagnolo, di cui è anche stata realizzata anche un’apposita versione. “If I Was Your Mother” è puro rock a stelle e strisce: riff roccioso, produzione solida e pochi fronzoli. Melodica, d’impatto e carica di pathos, con un solo mozzafiato di Sambora a impreziosirne la qualità.
Leggi anche: Il grande cuore di Jon Bon Jovi: regala 77 case ai veterani di guerra
Poi c’è “Dry County“. E qui, scusate, però mi prendo la licenza di affermare che molto probabilmente è tra le canzoni più belle mai scritte dalla band. Quasi dieci minuti di stravolgimenti emotivi, di continui cambi tempo e di atmosfera, tra sfumature e suggestioni sensazionali. Un pezzo con un trasporto empatico come pochi altri ne sono stati scritti prima e dopo. Cori e controcori magistrali, solos al fulmicotone, e una sezione ritmica esemplare. Ineguagliabile.
Sarebbe peccato mortale non considerare i brani che da “Woman in Love” in poi chiudono il pattern, ma è innegabile che questi primi sette spicchino su tutto il resto. Provare, inoltre, a classificarli in ordine di volgare e superficiale “bellezza” equivarrebbe a pressappochismo e futilità. Questa song è infatti tutto fuorché tralasciabile: blueseggiante, easy listening e ben composta, farebbe invidia a molte discografie di gruppi altrettanto blasonati. “Fear” invita ad affrontare con coraggio e determinazione gli ostacoli che si trovano sulla nostra strada e l’influenza di Bob Rock si sente, e come se si sente. “I Want You” è l’altra ballata presente nella tracklist, epica e intimista. Chiudono l’album “Blame It on the Love of Rock & Roll” e “Little Bit of Soul“, piccole perle che meriterebbero maggiori considerazioni. Voto? Un nove pieno.